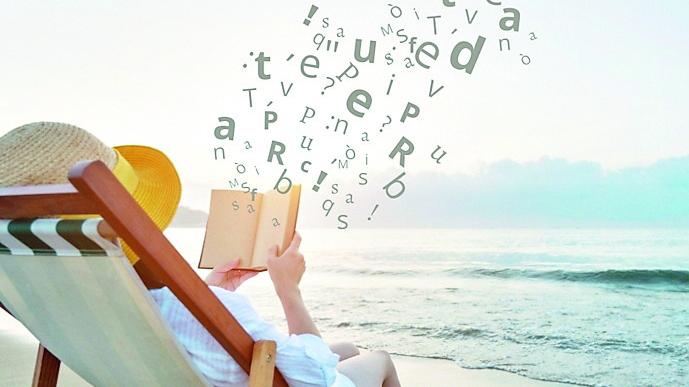Leggere è vivere
Come disse Umberto Eco, «Chi non legge, a settant’anni avrà vissuto una sola vita. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni».
Se per noi oggi l’alternanza delle stagioni rappresenta una semplice rottura della monotonia, per gli antichi era una legge regolatrice, gli umani erano schiavi della natura e dipendevano dai suoi frutti. Tuttavia, non era per questo meno affascinante: i Greci avevano personificato le stagioni nelle Ore, figlie di Zeus e di Temi, e ne avevano spiegato la successione con il mito di Persefone; dopo essere stata rapita da Ade, la dea si era cibata di un melograno degli inferi, ma solo di metà, e per questo era costretta a rimanere nell’oltretomba per sei mesi l’anno. Quando poteva riemergere, la madre Demetra permetteva al mondo di germogliare.
«Autunno. Già lo sentimmo venire nel vento d'agosto, nelle pioggie di settembre torrenziali e piangenti» scrive Vincenzo Cardarelli: con questa metafora rappresenta le problematiche della vita adulta, talmente opprimenti da impedire all’uomo di godersi la giovinezza. Questa tesi è condivisa anche da Leopardi nel Sabato del Villaggio; il sabato simboleggia l’infanzia, felice e ancora ignara delle cure umane, la domenica invece, non può essere apprezzata poiché grava su di noi la settimana ventura (età adulta) con tutti i suoi “travagli”.
L’analogia tra la caducità della giovinezza (e della vita) e le foglie è antichissima, il primo di una lunga lista è stato il poeta elegiaco Mimnermo, al quale si ispirerà anche Ungaretti per comporre Soldati. Nel frammento Come le foglie, incarna il male assoluto nella vecchiaia, durante la quale l’uomo non sarebbe nemmeno degno di essere amato, invece la beata giovinezza ci riserva tutti i doni degli dei. Ciò che rende preziosa la vita la nostra esistenza è proprio la sua natura effimera. La consapevolezza che ogni momento è unico e racchiude la bellezza della vita. La vita è una soltanto, non si può vivere nascosti, mostrarci per qualcosa che non siamo, agire con la paura di discostarci dalla massa. L’unicità della vita appare però spaventosa a chi non conosce la sua strada, a chi sa che tra la vasta gamma di percorsi solo uno sarà quello che possiamo imboccare. Nel romanzo semi-autobiografico La Campana di Vetro, Sylvia Plath, poetessa statunitense, riesce a condensare l’esperienza umana in un’analogia geniale. Osservando l’albero di fichi nel suo giardino, contempla i vari frutti, uno più grosso, uno dall’aspetto più succoso, un altro maturo; impossibile sceglierne uno solo, tanto che si trova immobile, incapace di compiere la scelta, e i frutti iniziano a cadere ai suoi piedi, marciti. Così l’autrice non riesce neanche a trovare la sua strada: diventare famosa per le sue parole, scappare con l’uomo che la ama, dedicarsi a degli ipotetici figli, girare il mondo senza una fissa dimora. Questa è la sorte di chi ama troppo, di chi apprezza le piccole cose ma non si accontenta mai, di chi ha una sete di conoscenza tale che non basterebbero cento vite. È la sorte di chi non potrà mai imparare tutte le lingue, abitare tutte le città, esercitare ogni professione. L’unica arma di cui disponiamo è la nostra curiosità: ascoltando più storie possibili siamo capaci di rendere nostra una storia altrui. In questo modo, come disse Umberto Eco, «Chi non legge, a settant’anni avrà vissuto una sola vita. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni».
*Gian Marco studia al liceo Azuni di Sassari