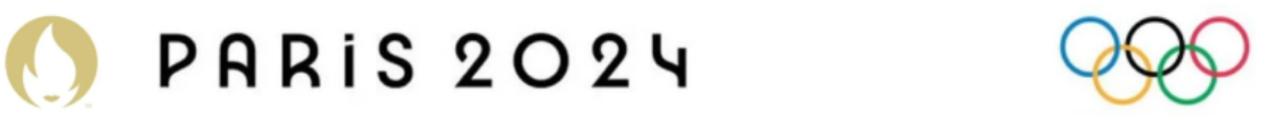Il caso Carini-Khelif: «Aboliamo le basi razziste dello sport»
«Basta sputare sulle esperienze di noi donne transgender, si inizi a parlare del sistema che ha portato alla discriminazione di genere»
È da giorni che è scoppiata una polemica sull’incontro di pugilato fra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. Subito, viene diffusa la notizia che la Khelif è una donna transgender.
I commenti sono i soliti: “state rovinando lo sport femminile”; “gli uomini si travestono da donne per vincere le competizioni femminili”; accompagnati da insulti variopinti rivolti alla comunità trans*.
Essere transgender è un percorso caratterizzato da sofferenza e fatica. È un percorso dettato dalla necessità di sopravvivere, di ricercare la tranquillità. Essere transgender vuol dire avere un’incongruenza di genere, quindi, non identificarsi nel genere che è stato assegnato alla nascita. Non è una scelta, ma una necessità, perché nessuna persona si sveglia un giorno e decide di intraprendere un percorso di affermazione di genere. Una persona transgender può decidere se svolgere un percorso di affermazione di genere sociale.
Chi ha un’identità di genere concorde al genere assegnato alla nascita, si chiama “cisgender”. Non lo sapevate, vero? La ricerca scientifica non ha dimostrato alcun tipo di vantaggio biologico significativo fra le atlete cisgender e le atlete transgender. Quindi, anche ammettendo che la Khelif fosse una donna transgender, la polemica sarebbe stata sterile. Ma la Khelif non è transgender, e si tratta di una questione diversa.
Iniziamo usando la logica: le testate giornalistiche e i mezzi di informazione che hanno affermato che la Khelif è trans, evidentemente sono ignare di un dettaglio non poco rilevante: la Khelif è algerina, e in Algeria le persone trans non hanno diritti. Figuriamoci se possono partecipare alle Olimpiadi. La Khelif è una donna con una variazione intersessuale, termine che nessun mezzo di informazione conosce, perché ancora invisibile. La parte più imbarazzante di questo caso è proprio l’invisibilizzazione delle persone intersex.
Il fatto che la società continui a proporre lo stereotipo (e informazione scientificamente sbagliata) che XX vuol dire femmina e XY vuol dire maschio. Ma non vorrei dilungarmi oltre, perché non sono una persona intersex e non penso di poter parlare al posto loro. Parliamo invece dello stereotipo di genere che ancora oggi colonizza lo sport femminile. Parliamo di come lo sport abbia basi razziste e sessiste, creando standard che hanno come unità di misura l’uomo bianco cisgender. Parliamo di come la performance sportiva femminile sia chiusa in una gabbia, e quando una donna si azzarda a uscire da quelle sbarre viene accusata di essere un’impostora, di aver barato o addirittura di essere un uomo. Parliamo del fatto che se il vantaggio biologico di Michael Phelps gli ha garantito fama e vittoria, a Caster Semenya e Imane Khelif sono state lanciate accuse infondate. Questo atteggiamento verso lo sport femminile, non è dannoso solo per le donne transgender e intersessuali.
È dannoso per tutte le donne, comprese quelle cisgender, perché ogni volta che una donna esce fuori da quel recinto che le è stato costruito attorno, allora diventa un problema per la società. Lo sport femminile viene considerato più noioso di quello maschile, che invece sprizza dinamicità e virilità da tutti i pori. Si sa, dopotutto, che le donne devono prima di tutto essere carine e delicate. La verità invece, è che le donne non svolgono una performance più noiosa o debole, ma che sono educate e costrette a farlo.
Quindi, invito i mezzi di informazione italiani a rivedere le proprie priorità: forse è il caso di smettere di sputare sulle esperienze di noi donne transgender, forse è il caso di iniziare a parlare del sistema che ha portato alla discriminazione di genere. Forse è il caso di iniziare a lasciare in pace la comunità trans* e intersessuale, e di iniziare a parlare di come l’ambiente sportivo sia altamente sessista.