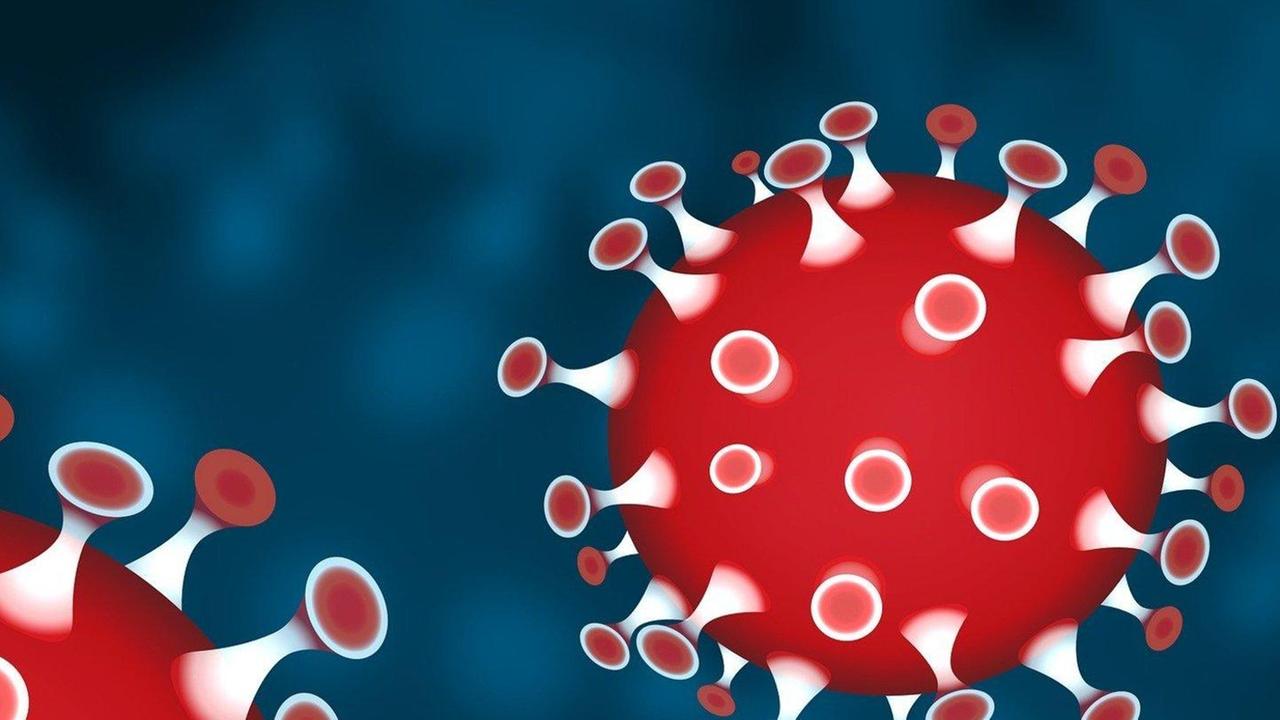Dentro il ciclo della paura, le città ai tempi del Covid
di Costantino Cossu
Antonietta Mazzette parla dei risultati di una ricerca ora raccolti in un libro su insicurezza e timori, speranza e socialità di fronte alla sfida della pandemia
5 MINUTI DI LETTURA
Una ricerca sociologica sullo stato di insicurezza, paura, fiducia e socialità dei cittadini italiani in tempi di pandemia. I risultati sono contenuti nel libro “Città e territori in tempi di pandemia” (Franco Angeli, 200 pagine, 27,00 euro) curato da Antonietta Mazzette, da Daniele Pulino e da Sara Spanu, con una postfazione di Giovanni Meloni.
«La ricerca – spiega Mazzette – è stata avviata nel periodo più traumatico della pandemia, quando nessuno poteva ipotizzare che gli studi sui vaccini sarebbero andati a buon fine dopo pochi mesi. Ricordo anche che l’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato colpito, registrando un alto numero di contagi (e di mortalità) del virus Sars Cov2. Ora ci sembrano lontani ‘anni luce’ quei circa tre mesi di chiusura totale della nostra società, se non per quelle attività necessarie per la sopravvivenza delle persone, ma come sociologi abbiamo pensato che l’impatto che il lockdown nazionale stava creando sui cittadini fosse un’occasione irripetibile per ‘tastare’, per così dire, loro il polso. In altre parole, con la nostra ricerca abbiamo voluto tanto fissare quel momento storicamente dato, sotto il profilo degli effetti sociali, quanto ricavare dalle parole dei nostri intervistati quali potessero essere le soluzioni per uscire dallo stato di crisi».
La vostra ricerca individua i diversi ambiti in cui la pandemia ha inciso sui modi di vivere le realtà urbane. A cominciare da quello della socialità. Com’è cambiato il nesso tra rapporti sociali e spazi urbani?
«Nella prima fase acuta possiamo dire che il legame tra dimensione sociale e dimensione fisica si è di fatto interrotto. Naturalmente gli esseri umani non possono vivere senza socializzare, ovvero senza rapportarsi con gli altri a seconda dei distinti e individuali interessi. Ma la loro vita quotidiana si è spostata fisicamente dentro le abitazioni e virtualmente sulle diverse piattaforme social, anche se questo spostamento è avvenuto in modo fortemente diseguale. In questa fase l’Italia ha colmato in tempi rapidi quel gap che la collocava agli ultimi posti in Europa per l’utilizzo delle tecnologie digitali. Non a caso l’economia digitale non ha conosciuto la crisi che ha colpito la maggior parte delle altre attività economiche. Basti pensare che i ricavi di Amazon nel primo trimestre del 2020 registreranno un aumento del 26%, rispetto allo stesso periodo dell’anno recedente, percentuale superata ampiamente nei mesi successivi. Se però spostiamo lo sguardo su ciò che avverrà nelle fasi successive – con periodi di lockdown nazionale limitati alle festività natalizie e pasquali e con regioni “a colori”, a seconda dell’incidenza del contagio – vediamo la formazione di atteggiamenti opposti tra chi continua ad essere cauto cambiando drasticamente le sue abitudini e quindi luoghi di frequentazione, e chi invece non ha modificato le proprie abitudini: basti osservare ciò che puntualmente avviene nei fine settimana».
Come è cambiata la domanda di sicurezza durante la pandemia? Che cos’è il “ciclo della paura” di cui parlate nella vostra analisi?
«L’espressione “ciclo della paura” è stata utilizzata in ambito sociologico per la cosiddetta influenza suina del 2009. Noi l’abbiamo applicata all’evoluzione dell’atteggiamento di inquietudine degli individui durante l’evento pandemico – classificando i prodromi, la fase acuta e la tendenza alla normalizzazione – e collegandola ai cambiamenti della domanda di sicurezza, ma soprattutto di fiducia della popolazione italiana verso le istituzioni. Sulla base di questa scansione abbiamo rilevato che da una fiducia quasi totale verso le azioni governative si è passati a una crescita della diffidenza che corrisponde, paradossalmente, con la crescita di protezione dal virus grazie ai vaccini».
Un altro aspetto importante del quadro pandemico è quello della mobilità. In proposito che cosa è stato possibile rilevare?
«I nostri interlocutori hanno posto in evidenza “antichi” problemi strutturali, peraltro ampiamente affrontati dai sociologi urbani. Si tratta degli effetti perversi dovuti alla cementificazione del suolo, alla separazione e specializzazione funzionale delle città, alle politiche urbane basate sui diversi registri di vita sociale fondati sul consumo. Questi problemi hanno accresciuto la mobilità quotidiana di molti cittadini e, in tempi di pandemia, ciò è diventato fonte di rischio. In merito i nostri interlocutori sono stati molto concreti, esprimendo una domanda di mobilità sostenibile che garantisca a tutti un accesso equo alle risorse».
C’è stato anche un flusso rilevante, in termini di residenza, dalle città ai piccoli paesi?
«Sarei cauta nell’affermare che i piccoli paesi siano stati destinazione di flussi di popolazione urbana, nonostante il gran parlare mediatico per la notorietà di chi ha lanciato questo slogan. Alla domanda specifica la maggior parte dei nostri interlocutori risponde che considera altamente improbabile un ritorno ai borghi. E ciò perché l’offerta urbana di servizi e le possibilità di connessioni sociali, di attività lavorative, di svago e consumo appaiono elementi irrinunciabili anche a quanti, invece, auspicano una rivitalizzazione dei piccoli insediamenti».
Che cosa servirebbe perché la pandemia sia davvero un’occasione di ripensamento del vivere urbano in tutte le sue dimensioni?
«Intanto dovremmo domandarci se l’emergenza sanitaria abbia effettivamente messo in crisi la natura stessa delle città contemporanee, a partire dalla sua economia. Allo stato attuale delle cose ciò non emerge in concreto. Possiamo però dire che alcuni caratteri sembrano essere suscettibili di cambiamenti. Faccio un solo esempio: i processi economici sempre meno ancorati al territorio hanno reso le città – in particolare quelle italiane – ancor più vulnerabili. Basti pensare al fatto che durante la prima fase dell’epidemia gran parte della popolazione italiana non poteva disporre di mascherine e igienizzanti, perché nei decenni precedenti la delocalizzazione della produzione aveva portato l’Italia (ma in realtà quasi tutta l’Europa) a dipendere in toto dalla produzione industriale di altri Paesi, soprattutto della Cina. Ecco, aver toccato con mano l’impossibilità di accedere ad alcuni beni necessari, forse sta servendo a riportare al centro della nostra attenzione l’importanza della produzione materiale. Ciò vale per quasi tutti i settori dell’economia».
Quali possono essere le prospettive future?
«Bisognerebbe partire dalle fragilità del sistema urbano che la pandemia ha reso più evidenti in termini organizzativi, abitativi e lavorativi e tradurle in interventi concreti, sapendo che vi sono popolazioni profondamente diverse tra loro per capacità economiche e culturali di accesso alle risorse. Basti pensare alle condizioni di vita delle persone che sono andate aggravandosi nelle tante periferie italiane, anche in termini di accesso ai beni essenziali come il cibo. Nel nostro libro queste fragilità emergono con chiarezza. Risolvere queste fragilità attiene alla duplice capacità di governare e di essere governati, capacità attualmente bassa a partire dal livello locale. Ma questo apre un altro ordine di problemi».
«La ricerca – spiega Mazzette – è stata avviata nel periodo più traumatico della pandemia, quando nessuno poteva ipotizzare che gli studi sui vaccini sarebbero andati a buon fine dopo pochi mesi. Ricordo anche che l’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato colpito, registrando un alto numero di contagi (e di mortalità) del virus Sars Cov2. Ora ci sembrano lontani ‘anni luce’ quei circa tre mesi di chiusura totale della nostra società, se non per quelle attività necessarie per la sopravvivenza delle persone, ma come sociologi abbiamo pensato che l’impatto che il lockdown nazionale stava creando sui cittadini fosse un’occasione irripetibile per ‘tastare’, per così dire, loro il polso. In altre parole, con la nostra ricerca abbiamo voluto tanto fissare quel momento storicamente dato, sotto il profilo degli effetti sociali, quanto ricavare dalle parole dei nostri intervistati quali potessero essere le soluzioni per uscire dallo stato di crisi».
La vostra ricerca individua i diversi ambiti in cui la pandemia ha inciso sui modi di vivere le realtà urbane. A cominciare da quello della socialità. Com’è cambiato il nesso tra rapporti sociali e spazi urbani?
«Nella prima fase acuta possiamo dire che il legame tra dimensione sociale e dimensione fisica si è di fatto interrotto. Naturalmente gli esseri umani non possono vivere senza socializzare, ovvero senza rapportarsi con gli altri a seconda dei distinti e individuali interessi. Ma la loro vita quotidiana si è spostata fisicamente dentro le abitazioni e virtualmente sulle diverse piattaforme social, anche se questo spostamento è avvenuto in modo fortemente diseguale. In questa fase l’Italia ha colmato in tempi rapidi quel gap che la collocava agli ultimi posti in Europa per l’utilizzo delle tecnologie digitali. Non a caso l’economia digitale non ha conosciuto la crisi che ha colpito la maggior parte delle altre attività economiche. Basti pensare che i ricavi di Amazon nel primo trimestre del 2020 registreranno un aumento del 26%, rispetto allo stesso periodo dell’anno recedente, percentuale superata ampiamente nei mesi successivi. Se però spostiamo lo sguardo su ciò che avverrà nelle fasi successive – con periodi di lockdown nazionale limitati alle festività natalizie e pasquali e con regioni “a colori”, a seconda dell’incidenza del contagio – vediamo la formazione di atteggiamenti opposti tra chi continua ad essere cauto cambiando drasticamente le sue abitudini e quindi luoghi di frequentazione, e chi invece non ha modificato le proprie abitudini: basti osservare ciò che puntualmente avviene nei fine settimana».
Come è cambiata la domanda di sicurezza durante la pandemia? Che cos’è il “ciclo della paura” di cui parlate nella vostra analisi?
«L’espressione “ciclo della paura” è stata utilizzata in ambito sociologico per la cosiddetta influenza suina del 2009. Noi l’abbiamo applicata all’evoluzione dell’atteggiamento di inquietudine degli individui durante l’evento pandemico – classificando i prodromi, la fase acuta e la tendenza alla normalizzazione – e collegandola ai cambiamenti della domanda di sicurezza, ma soprattutto di fiducia della popolazione italiana verso le istituzioni. Sulla base di questa scansione abbiamo rilevato che da una fiducia quasi totale verso le azioni governative si è passati a una crescita della diffidenza che corrisponde, paradossalmente, con la crescita di protezione dal virus grazie ai vaccini».
Un altro aspetto importante del quadro pandemico è quello della mobilità. In proposito che cosa è stato possibile rilevare?
«I nostri interlocutori hanno posto in evidenza “antichi” problemi strutturali, peraltro ampiamente affrontati dai sociologi urbani. Si tratta degli effetti perversi dovuti alla cementificazione del suolo, alla separazione e specializzazione funzionale delle città, alle politiche urbane basate sui diversi registri di vita sociale fondati sul consumo. Questi problemi hanno accresciuto la mobilità quotidiana di molti cittadini e, in tempi di pandemia, ciò è diventato fonte di rischio. In merito i nostri interlocutori sono stati molto concreti, esprimendo una domanda di mobilità sostenibile che garantisca a tutti un accesso equo alle risorse».
C’è stato anche un flusso rilevante, in termini di residenza, dalle città ai piccoli paesi?
«Sarei cauta nell’affermare che i piccoli paesi siano stati destinazione di flussi di popolazione urbana, nonostante il gran parlare mediatico per la notorietà di chi ha lanciato questo slogan. Alla domanda specifica la maggior parte dei nostri interlocutori risponde che considera altamente improbabile un ritorno ai borghi. E ciò perché l’offerta urbana di servizi e le possibilità di connessioni sociali, di attività lavorative, di svago e consumo appaiono elementi irrinunciabili anche a quanti, invece, auspicano una rivitalizzazione dei piccoli insediamenti».
Che cosa servirebbe perché la pandemia sia davvero un’occasione di ripensamento del vivere urbano in tutte le sue dimensioni?
«Intanto dovremmo domandarci se l’emergenza sanitaria abbia effettivamente messo in crisi la natura stessa delle città contemporanee, a partire dalla sua economia. Allo stato attuale delle cose ciò non emerge in concreto. Possiamo però dire che alcuni caratteri sembrano essere suscettibili di cambiamenti. Faccio un solo esempio: i processi economici sempre meno ancorati al territorio hanno reso le città – in particolare quelle italiane – ancor più vulnerabili. Basti pensare al fatto che durante la prima fase dell’epidemia gran parte della popolazione italiana non poteva disporre di mascherine e igienizzanti, perché nei decenni precedenti la delocalizzazione della produzione aveva portato l’Italia (ma in realtà quasi tutta l’Europa) a dipendere in toto dalla produzione industriale di altri Paesi, soprattutto della Cina. Ecco, aver toccato con mano l’impossibilità di accedere ad alcuni beni necessari, forse sta servendo a riportare al centro della nostra attenzione l’importanza della produzione materiale. Ciò vale per quasi tutti i settori dell’economia».
Quali possono essere le prospettive future?
«Bisognerebbe partire dalle fragilità del sistema urbano che la pandemia ha reso più evidenti in termini organizzativi, abitativi e lavorativi e tradurle in interventi concreti, sapendo che vi sono popolazioni profondamente diverse tra loro per capacità economiche e culturali di accesso alle risorse. Basti pensare alle condizioni di vita delle persone che sono andate aggravandosi nelle tante periferie italiane, anche in termini di accesso ai beni essenziali come il cibo. Nel nostro libro queste fragilità emergono con chiarezza. Risolvere queste fragilità attiene alla duplice capacità di governare e di essere governati, capacità attualmente bassa a partire dal livello locale. Ma questo apre un altro ordine di problemi».